-
.
4
Se consideriamo la parola evangelica: “Ama il tuo prossimo come te stesso”, che non significa né: “Ama il tuo prossimo più di te stesso”, né: “Non amare te stesso”, ma piuttosto: “Non distinguere il tuo prossimo da te stesso”. Se teniamo conto che questa parola è stata pronunciata da Cristo che ha compiuto volontariamente un supremo sacrificio umano, comprenderemo la piccola importanza che, ove fosse regolarmente istituito il sacrificio umano, dovrebbe essere considerato relativamente al benessere fisico o psichico della persona immolata; deve contare solo l'interesse spirituale, con tutto ciò che comporta, oltre ovviamente ai vantaggi individuali.
Il sacrificio di Cristo è ciò che permette ai cattolici di macellare animali senza sacrificarli, poiché Cristo contiene, attraverso la sua divinità, ogni manifestazione; per questo per i cattolici, il sacrificio di un animale sarebbe una sorta di pleonasmo; sono come “coperti” o protetti dal sacrificio di Cristo che, come abbiamo appena detto, sintetizza in sé la totalità degli esseri. Non è lo stesso per i protestanti o i non credenti che non hanno il diritto di togliere la vita finché l’uomo non è capace di darla e che, quando uccidono senza sacrificio, attirano sulla loro testa una sorta di vendetta da parte della specie animale. Senza dimenticare il castigo della Divinità verso la quale l'uccisione da macellai profani è una sorta di furto e di oltraggio. Si tratta senza dubbio di una coscienza vaga e istintiva di queste conseguenze che portano alcuni ad aderire al vegetarianismo come se fosse una religione; possiamo dire che lo fanno per cattiva coscienza, senza ovviamente rendersi conto di quanto sia logico e prudente per loro il loro vegetarianismo; perché se lo capissero, non esiterebbero un attimo ad attaccarsi a una tradizione, piuttosto che cercare di sfuggire a certi effetti di eterodossia o di incredulità. Per quanto riguarda i popoli che vivono di caccia, non si può dire che uccidano necessariamente alla maniera del laico del mondo moderno; non c’è certamente nessun popolo, al di fuori del mondo moderno, che sia privo di ogni legame tradizionale dove l’uomo è vincolato da disposizioni rituali, o che queste si estendano a tutto, o che l'uomo ne sia esentato in certi casi per una sorta di compensazione tradizionale, come nel caso dei cattolici che possono uccidere animali senza rito.
È però probabile che alcuni popoli omettano, a causa della degenerazione, i riti che osservavano originariamente; ogni atto della vita e in particolare anche la caccia, base della loro esistenza materiale, è sacro: ad esempio, il cacciatore pellerossa, quando aveva ucciso un bisonte, fumava davanti a lui la pipa, la “pipa di Pace”, uno strumento rituale fatto di argilla sacra e soffiava il fumo, che era solito dirigere nelle sei direzioni dello spazio, verso il muso dell'animale ucciso, per riconciliarsi, in qualche modo, con ciò che possiamo chiamano il “genio della specie”. Riti abbastanza simili si svolgono tra gli Enos e la maggior parte dei popoli della Siberia, e anche tra i Pigmei africani.
Abbiamo detto sopra che il sacrificio umano rischia di deviare, in certi casi, come può avvenire anche per qualsiasi simbolo, dal “qualitativo” al “quantitativo” o dal rito alla superstizione, così da condurre a qualcosa di diametralmente opposto al sacrificio originario; questo caso era quello degli Aztechi e di numerose tribù più o meno degenerate. Dove la spiritualità si è ottenebrata, un sacrificio o una preghiera non sono più rivolti alla Divinità o ad uno dei suoi aspetti, ma ad un'entità psichica creata e mantenuta dall'adorazione collettiva, adorazione che, anch'essa, è solo psichica; non possiamo dire che in una tradizione normale un'entità simile sia assente ma è di minore importanza e di maggiore sostanza e serve semplicemente da supporto agli influssi divini, così come, nell'individuo, gli elementi psichici o la salute mentale svolgono un ruolo importante. ruolo analogo in relazione alle irradiazioni dell'intelletto.
Quando le influenze divine si sono ritirate da una forma tradizionale e questa entità sussiste sola, abbandonata a sé stessa e ai suoi servi ignoranti, quest'ultimo diventa inevitabilmente un vampiro psichico e funge da dimora e strumento per le influenze oscure; è per questo motivo che Maometto rovesciò gli idoli della Mecca, divenuti fondamentali condensatori di tali influenze; questo spiega anche perché uno dei musulmani contemporanei del Profeta poté vedere, nel momento in cui ruppe un idolo e recitò la shahâdah, un'apparizione nera e orribile che fuoriusciva dall'interno della statua.
Il sacrificio come ogni culto può degenerare in qualcosa di analogo all'idolatria, per poi diventare orgiastico e servire solo a nutrire un'entità psichica mostruosa, creata, come abbiamo detto, dalle emanazioni psichiche dei suoi adoratori e assetata del sangue che è il suo supporto vitale. Deviazioni di questo tipo si verificano sempre la dove le forme di culto non siano più adatte alle condizioni del momento ciclico; queste forme non sono allora altro che vestigia che continuano a vivere una vita puramente meccanica, così come un corpo decapitato può ancora subire contrazioni nervose. È allora che, nella maggior parte dei casi, interviene o una forma tradizionale adattata alle condizioni cicliche, oppure la distruzione pura e semplice.
In questa ottica, dobbiamo stare attenti a non confondere le deviazioni stesse con le forme in cui si manifestano, forme che sconcertano l'immaginazione e il sentimento per la semplice ragione che non sono più conformi alle condizioni generali dei nostri tempi ciclici; non si può quindi affermare che il cannibalismo, ad esempio, costituisca in sé una deviazione e che abbia ovunque e sempre il carattere riprovevole che può avere tra i selvaggi che lo praticano; che sia, invece, capace di un significato positivo ed elevato risulta chiaramente da un rito come la comunione cattolica. Riguardo a questa dobbiamo ricordare le parole di Cristo che la istituì, parole il cui simbolismo non sarebbe possibile se non si riferisse ad una realtà corrispondente al loro significato immediato e letterale.
La comunione, infatti, non è estranea al consumo rituale della carne umana; in entrambi i casi è per appropriarsi delle qualità della persona sacrificata che se ne consuma la carne, siano esse qualità spirituali o divine come nel caso dell'Eucaristia, o semplicemente umane come in quello dell'antropofagia dei selvaggi. Viceversa, è per non appropriarci di certe qualità di ordine inferiore che evitiamo di mangiare certi animali, questo è il senso della proibizione della carne di maiale presso i semiti monoteisti; l'animale atto a servire da cibo all'uomo deve quindi essere, in un certo senso, un animale sacro, concetto che esprimiamo dicendo che è «puro» e questo ci avvicina nuovamente al simbolismo della comunione cristiana. Se in quest'ultimo la quantità delle «specie» non ha alcun ruolo, è sempre in virtù della legge insita in ogni simbolismo, legge che esige una rigorosa subordinazione dell'aspetto sostanziale o quantitativo a quello essenziale e qualitativo, un rapporto che è dimostrato, come abbiamo detto, dal rifiuto di Cristo di lavare l'intero corpo di san Pietro. Questa legge spiega perché le esagerazioni viziose, come la golosità o la lussuria, non sono suscettibili di sacralizzazione, mentre l'alimentazione e la convivenza lo sono proprio grazie alla loro qualità simbolica fondata su analogie ontologiche o, per parlare senza alcuna restrizione, su quello metafisico. Analogie che collegano qualsiasi simbolo al Principio divino.
Dobbiamo ancora rispondere, in questa occasione, alla seguente obiezione: con quale “diritto” un sacerdote può immolare un individuo contro la volontà di quest'ultimo? La risposta è data dall'esempio del guerriero indiano che sacrifica un dito a Vakonda: con quale “diritto” le dita della mano destra tagliano un dito della mano sinistra? Da questo esempio consegue immediatamente che il sacrificante non agisce evidentemente come individuo, ma semplicemente come strumento della comunità la quale, essendo la totalità, ha ovviamente tutti i diritti sulla propria parte, l'individuo, a condizione ovviamente che questa totalità sia unita da un legame spirituale, legame che è rappresentato, nell'esempio del guerriero indiano, dalla sua intelligenza che governa le sue azioni; da questo punto di vista la reazione dell'individuo, umano o animale, non ha alcuna importanza, né per la validità del rito, né per le condizioni postume dell'individuo immolato.
5
Anche la guerra feudale comporta un aspetto di sacrificio, non perché rappresenti una manifestazione del tutto generale delle condizioni sfavorevoli della nostra epoca ciclica ma piuttosto in quanto ha un significato positivo e che, per questo, rappresenta un tipo di legge, un modus vivendi o una disciplina per una data comunità umana. In questo senso, molti sarebbero ancora gli sviluppi da fare su un'altra modalità di sacrificio di carattere bellico, il seppuku, conosciuto in Occidente più in generale sotto il nome di harakiri, il suicidio rituale degli shintoisti. Quanto abbiamo detto in precedenza contiene implicitamente gli elementi necessari per comprendere questo caso così particolare di sacrificio umano; una sola osservazione ci sembra opportuna a questo proposito e cioè che l'harakiri, per il fatto che costituisce un rito attinente ad una prospettiva tradizionale che, per definizione, è una sorta di sistema chiuso ed omogeneo i cui elementi non sono in alcun modo assimilabili ad altre forme tradizionali, essendo compossibili solo nel loro stesso quadro, - l'harakiri, diciamo, non rientra in alcun modo sotto la legge del suicidio volgare e non rituale, perché “coperto” dalle disposizioni tradizionali dello Shintoismo.
Di carattere alquanto diverso era il sacrificio dei re, un'altra forma di suicidio rituale praticato anticamente in alcune parti dell'India e in diversi altri paesi: il sovrano, dopo aver regnato per un determinato numero di anni, doveva mettersi a morte mediante tortura assistito dal suo successore e dal popolo riunito. Del resto, il codice sacro degli indù, il Mānava-Dharma-Śāstra, contiene diverse disposizioni che possono essere considerate appartenenti a questa stessa categoria di fatti scaturiti dall'idea di sacrificio, fatti che urtano estremamente l'immaginazione individualista dei moderni.
Non sorprende, dato lo sviluppo specificamente individualistico della civiltà occidentale, che in Occidente rimanga poca traccia di questa idea fondamentale del sacrificio, lasciando da parte, ovviamente, l’immolazione giudeo-islamica e l’Eucaristia cattolica e che inoltre le ultime manifestazioni rituali di questa idea sono oggetto, in alcuni paesi, di divieti che sembrano voler completare la rottura, già per tanti aspetti realizzata, tra l'uomo e Dio.
6.
Esiste, oltre al sacrificio stesso, un'altra modalità di realizzazione della stessa idea, una modalità che riguarda non la comunità, ma il singolo individuo, almeno nell'immediato: ed è in quest'ordine che vanno collocate le pratiche ascetiche, dalle semplici astensioni alle macerazioni metodiche o violente in cui si impegnano certi asceti.
In questo ordine di idee, però, il sacrificio non ha più lo stesso valore rigorosamente definito che aveva nell'ordine strettamente ritualistico: questo è soprattutto un supporto speculativo per chi lo pratica e la sua forma o qualità ha solo valore in questo senso, tanto che sarebbe errato attribuire ad una data forma di pratica ascetica un valore assoluto che solo il frutto spirituale ottenuto mediante tale pratica potrebbe avere. In altri termini, il sacrificio ascetico ha valore solo nella misura in cui suggerisce, attraverso il suo simbolismo vissuto e grazie alla sua virtù trasformatrice che lo assimila simbolicamente al fuoco, verità trascendenti. È valido solo nella misura in cui aiuta a prendere contatto con la spiritualità. realtà o stati superiori; solo questo conta qui, qualunque sia la strada che ad esso conduce e tutte le pratiche possibili, per quanto indispensabili possano essere per questo o quell'individuo, sono poco alla luce della Conoscenza.
Dare un valore assoluto all'astensione disciplinare, come il digiuno, il silenzio, la solitudine o la castità, che sono evidentemente sacrifici, equivale ad una sorta di superstizione di fatto, che facilmente avviene qualora si sia sostituito, almeno nella pratica, la morale all'idea; dimentichiamo allora le possibilità speculative inerenti al simbolismo del godimento, simbolismo che può senza dubbio essere sostituito da quello della sofferenza ma che, nella maggior parte dei casi, viene semplicemente più o meno compensato da questa, di modo che è l'equilibrio tra due simbolismi opposti a costituire il percorso.
Oltretutto, anche laddove ci poniamo quasi esclusivamente dal punto di vista del sacrificio, come nel cristianesimo e nel buddismo che non possono, dato il loro simbolismo fondamentale, porsi da un altro punto di vista, siamo obbligati a prendere parte al simbolismo opposto, e viceversa; sicché tra questi due simbolismi complementari c'è sempre, in ultima analisi, solo la predominanza dell'uno sull'altro, in conformità al simbolismo che determina la forma stessa della tradizione in questione.
In sintesi, se il sacrificio non viene imposto all'uomo in modo esclusivo; vale a dire in modo da non lasciare alcuno spazio ad un atteggiamento diverso, come vorrebbe chi gli attribuisce un valore assoluto, ritenendolo il solo mezzo per ottenere il fine supremo, è che non siamo a tutti gli effetti solo manifestazione; e possiamo dire che meno lo siamo, meno ci riguarda il sacrificio, nessuna contingenza dell'essere manifestato potrà mai raggiungere il nostro stato contemplativo.
D'altra parte, il sacrificio non si realizza necessariamente in perfetta simultaneità su tutti i livelli della nostra realtà e quindi il sacrificio supremo che è la povertà spirituale (el-faqr in arabo) è indipendente, in linea di principio, da atteggiamenti analoghi assunti su un piano inferiore o più esterno.
Potremmo ancora esprimerci diversamente, in senso quasi opposto rispetto alla formulazione precedente e dire che il sacrificio è necessario nella misura in cui è di ordine elevato, perché si identifica in ultimo con l'ottenimento di quello di cui è solo l'aspetto negativo ma allora non si tratta più di sacrificio nel senso ordinario, cioè nel senso di una privazione separata dal suo scopo.
La povertà spirituale, infatti, è un aspetto inseparabile della pienezza spirituale che è partecipazione diretta alla pienezza divina; e quando ci poniamo dal punto di vista di questa pienezza, in virtù di una grazia iniziatica, comprenderemo il significato di queste parole che abbiamo ascoltato da un derviscio arabo: “Non sono io che ho lasciato il mondo; È il mondo che mi ha lasciato.”
Frithjof Schuon. -
.
3
Quanto abbiamo detto circa la manifestazione e la sua realizzazione in modalità “vibratoria” ci permette di intravedere la portata del sacrificio nel senso consueto del termine. Questo sacrificio riguarda la manifestazione della vita terrena in modo immediato perché non può escludere i significati superiori che necessariamente comporta e, per trasposizione simbolica, l'intera manifestazione universale di cui la vita terrena, essendo un microcosmo, è ovviamente un simbolo. Il sacrificio cruento costituisce una sorta di reminiscenza del Principio trascendente che è al di là della vita e che ne è la Causa positiva e divina, o anche una sorta di riferimento all'Immanifesto da cui ontologicamente scaturisce ogni manifestazione. Essendo la vita un “dono” dato dalla Causa Universale che, in questo senso, è considerata “Creatrice”, coloro che beneficiano di questo dono devono, per spiritualizzarla fare riferimento alla sua qualità simbolica, per renderla così più prospera e più duratura, restituire al Creatore o al Donatore una parte del suo Dono, quindi della vita. Ciò costituisce un'affermazione spirituale identica a quella contenuta nella testimonianza della fede islamica: «Non esiste divinità, se non la Divinità” (la ilaha illà Llâh), o, nell’applicazione che qui più particolarmente calza: “Non c’è vita, se non è Vita”, nel senso trasposto e assoluto di cui questo termine può essere suscettibile.
Questa affermazione o questo omaggio formulato mediante il sacrificio, si ritrova nelle forme più diverse, cruente o non cruente: così, gli antichi greci versavano qualche goccia del vino che stavano per bere; molti popoli, ad esempio gli indù, mangiano solo dopo averne offerto una porzione alle divinità, per cui mangiano sostanzialmente solo resti sacrificali e se, musulmani ed ebrei, versano tutto il sangue dalla carne che consumano, la stessa intenzione gioca il ruolo principale. Aggiungeremo ancora un altro esempio di ordine diverso: i guerrieri di alcune tribù del Nord America sacrificavano, al momento della loro iniziazione guerriera, un dito al “Grande Spirito”. Va ricordato che le dita sono in un certo senso la cosa più preziosa per il guerriero, uomo d'azione, e che è proprio per questo che su di esse viene compiuto il sacrificio. D’altra parte, il fatto che abbiamo dieci dita e che ne sacrifichiamo una, cioè un decimo di ciò che rappresenta la nostra attività, è molto significativo, innanzitutto perché il numero dieci è quello del ciclo compiuto o pienamente realizzato, e poi per l'analogia che esiste tra il sacrificio di cui abbiamo appena parlato e la zakkât musulmana, che è l'elemosina ordinata dalla legislazione sacra, e che consiste appunto in una decima. Si dice poi che, per preservare e incrementare i beni, si evita che il ciclo della prosperità si chiuda, e ciò sacrificando la decima, cioè quella parte che costituirebbe appunto il completamento e la fine del ciclo. La parola zakkât ha il doppio significato di “purificazione” e di “crescita”, termini la cui stretta relazione appare molto chiaramente nell'esempio della dimensione delle piante. La parola zakkât deriva etimologicamente dal verbo zakâ, che significa “prosperare” o “purificare”, o, in un altro senso, “innalzare” o “pagare” il contributo sacro, o anche “aumentare”. Ricordiamo anche, in questo senso, l'espressione araba àîn, che non significa solo “Tradizione”, secondo la concezione più comune, ma anche “Giudizio” e, con una vocalizzazione leggermente diversa che fa sì che la parola venga poi pronunciata dayn, “debito”; anche qui valgono i rispettivi significati della parola, essendo la Tradizione considerata come il debito dell'uomo nei confronti del “Donatore” (el-Zahhâb) o il “Creatore” (el-Khâliq); e il “Giorno del Giudizio” (yawmi ed-Dîn) menzionato nella Fâtihah, “giorno” in cui Allah è chiamato il “Re” (mâlik), non è altro che il giorno del “pagamento del debito” dell’individuo verso la Causa universale che è la ragione sufficiente di tutti gli esseri individuali.
Per tornare al sacrificio cruento che, come abbiamo visto, riguarda particolarmente la vita, non c'è ovviamente nulla di arbitrario nel fatto che sia il sangue versato al Creatore o Principio Donatore, poiché il sangue, come sappiamo, è giustamente considerato il veicolo più immediato della vita, che si manifesta da un lato con la sua circolazione e dall'altro con il suo calore; è anche in esso che gli elementi psichici entrano in connessione con la modalità corporea, questo è uno dei motivi per cui, in certe tradizioni, il suo consumo è proibito. C'è, nel sacrificio stesso, qualcosa di analogo al salasso; il corpo del malato corrisponde allora alla comunità umana che dona il suo sangue, sia perdendo quello di alcuni membri di questa comunità, sia sostituendoli con animali. Qui tocchiamo una questione molto importante, quella della differenza tra sacrificio umano e sacrificio animale; infatti, quando ci poniamo dal punto di vista delle considerazioni precedenti, di ciò che implicitamente affermano, dobbiamo concludere che, per una comunità umana, sono gli esseri umani che devono costituire il pagamento della “decima”.
Ciò vale per una società in cui le condizioni cicliche non hanno ancora reso necessaria una espiazione del sacrificio cruento, vale a dire un trasferimento, per quanto riguarda la vittima, dall'uomo all'animale. D’altro canto, una società che, a causa di alcune condizioni cicliche, non può più trarre veramente beneficio dal sacrificio umano, rischierebbe di vederlo deviare, se lo mantenesse, in una direzione diametralmente opposta al significato originario e si rende allora necessaria la sostituzione della vittima umana con quella animale.
Questo trasferimento è perfettamente valido dal punto di vista della tecnica, per così dire, del sacrificio, purché gli animali, senza far parte ovviamente della specie umana, appartengano tuttavia allo stesso modo come noi alla comunità vivente e terrestre, in modo più particolare alla comunità degli esseri caratterizzati dallo stesso sangue caldo; così il sacrificio rende l'animale partecipe della vita tradizionale che, in ogni epoca ciclica, è espressione di una realtà spirituale che riguarda anche gli animali. Per delucidare pienamente questa questione, bisognerebbe fare riferimento alla teoria della comunità terrestre considerata come un essere unico con modalità molteplici e gerarchiche, un essere la cui modalità centrale è l'uomo; ma poiché queste considerazioni si riferiscono solo indirettamente alla teoria del sacrificio, dobbiamo limitarci a menzionarle a titolo puramente indicativo.
Possiamo anche notare che, sotto un altro aspetto, l'animale viene sacrificato in quanto è una proprietà preziosa dell'uomo; anche il sacrificio umano consiste, nello stesso rispetto, nell'immolare un bene, cioè il bene più prezioso della comunità umana o terrena: il sacrificio più prezioso, infatti, consiste nell'abbandono di una parte di colui che sacrifica, come ci ha mostrato l’esempio dei guerrieri indiani.
Il passaggio dal sacrificio umano al sacrificio animale è segnato, nelle tre tradizioni monoteistiche, dal sacrificio di una pecora sostituita da Dio al figlio di Abramo; Va notato, tuttavia, per coloro che vorrebbero opporsi al sacrificio umano per ragioni individualistiche, che Abramo non doveva avere questo punto di vista, così come non lo avevano i sacerdoti delle tradizioni in cui il sacrificio umano era un'istituzione regolare, come era il caso, ad esempio, in un'epoca relativamente molto vicina a noi, tra gli indù e, in forma non cruenta, tra i cinesi. -
.
2.
Applicando questa teoria alla stessa manifestazione universale, diremo che il “mezzo” della sua realizzazione è l'Esistenza e che la sua “vibrazione” è la sequenza ciclica alla quale sono sottomesse tutte le modalità della manifestazione universale. Potremmo anche considerare la differenziazione con-naturata nell'Universo manifesto come la sua modalità “vibratoria” di realizzazione. Il principio di questa manifestazione è allora l'Essere che rimane fuori dell'Esistenza e, in modo analogo, il principio del suono o qualsiasi altra percezione sensibile rimane fuori dal suo mezzo di realizzazione o rifrazione, vale a dire il tempo e lo spazio.
Abbiamo descritto in precedenza la vibrazione come implicante fermate o intervalli che si susseguono in un ritmo continuo; è bene però precisare che tali fermate o vuoti sono tali solo in relazione alle fasi positive della vibrazione, così come, nella vita di un essere terreno, i sonni sono solo soste in relazione allo stato di veglia e come, in un ciclo dell'esistenza individuale, le morti sono solo fermate rispetto alle vite; non esiste, infatti, alcuna soluzione di continuità in una “vibrazione”, o meglio, la soluzione di continuità che ivi osserviamo è solo apparente e molto relativa, come dimostra la perfetta omogeneità del “ritmo”. Ciò appare molto visibilmente quando rappresentiamo la vibrazione con una sinusoide: questa può essere considerata divisa in due parti dal suo asse orizzontale; la parte superiore e quella inferiore rappresenterebbero quindi rispettivamente le due fasi positiva e negativa della vibra-zione. La fase positiva formata dalla serie dei momenti di percezione, in una percezione sensibile si lascerebbe definire, in senso universale, come affermazione simbolica del principio immanifesto, quindi come manifestazione; la fase negativa, costituita da quelle che abbiamo chiamato le “fermate” o i “vuoti”, rappresenterebbe la ricapitolazione simbolica dello stato di non manifestazione; quanto alla linea che separa le due fasi vibratorie, potremmo considerarla come il limite dell'inversione tra l'immanifesto e il manifestato.
Trasponendo questa immagine nella modalità cosmica, arriviamo alla concezione di ciò che gli indù chiamano i “giorni” e le “notti” di Brahma, vale a dire l’alternanza ciclica riguardante la manifestazione universale, alternanza che permette di comprendere la manifestazione: da questo punto di vista esiste veramente una soluzione di continuità, poiché è solo tramite questa “vibrazione” cosmica che la manifestazione si dissolve effettivamente o, meglio, si reintegra nell'immanifestato, anche se, nel senso più profondo, dobbiamo considerare, anche qui, una sorta di continuità. D'altra parte, quanto più i riflessi simbolici di questa vibrazione universale si relativizzano, tanto più si manifesta la continuità delle fasi vibratorie. Nel mondo sensibile o corporeo non esistono più vere e proprie rotture tra queste fasi: così lo stato della veglia e quella del sonno sono sempre legate e unificate dalla vita che non cessa, così come, in un ordine molto meno ristretto, i cicli individuali o "vite" di uno stesso esse-re sono sempre legati dall'individualità di questo essere.
Questa legge comporta però una compensazione in senso opposto: se è vero che la discontinuità tra le fasi vibratorie è ridotta nei diversi ordini relativi, per il fatto che la vibrazione stessa avviene solo in un dominio molto ristretto e che non possono quindi esserci differenze così rigorose come quelle che, negli ordini superiori, si verificano a causa dell'infinità del Principio divino o della possibilità Universale, non è meno vero che questa continuità quasi “sostanziale” è compensata da una maggiore di-scontinuità nella la vibrazione come tale, che può poi essere realizzata in modo molto meno rigoroso che negli ordini più generali o universali: così, per prendere l'esempio del sonno, questo differisce solo molto relativamente dalla veglia, poiché l'individuo continua a vivere in entrambi gli stati; d'altro can-to, l'individuo può in una certa misura fare a meno del sonno e della veglia, che costituiscono ecce-zioni impossibili in un ordine così generale come quello della percezione sensibile o semplicemente dell'esistenza fisica, e ancor più negli ordini universali, dove nessuna eccezione può intervenire. Ma d'altra parte, se nell'Universale le fasi vibrazionali si susseguono rigorosamente, cioè se la sequenza ciclica non soffre di alcun divario, queste fasi o cicli stessi sono tanto più diversi tra loro degli altri, e questo perché il riassorbimento o reintegrazione del manifestato nell'immanifesto, invece di essere semplicemente simbolico, è qui efficace, come abbiamo detto sopra; mentre, se tra un sonno e l'altro non c'è quasi alcuna differenza, è proprio perché non esiste una reale soluzione di continuità.
In un ambito relativo come quello della vita terrestre considerandola in rapporto all'individuo che la subisce, non nella sua intima struttura, la legge universale del processo di manifestazione non deve essere realizzata o simboleggiata con rigore assoluto, poiché la volontà individuale è all'estremo opposto, in un certo senso, della volontà divina, cioè della determinazione di principio o universale.
È così perché gli ordini (le strutture) che appaiono relativamente più lontani dall'immutabilità principiale sono in tal modo specchi del Principio divino in virtù del rapporto di inversione che opera tra Principio e manifestazione. ed essendo la volontà individuale, nella sua essenza positiva e nella sua realtà, un riflesso della Libertà divina, essa può apparentemente contraddire la legge naturale, e realizzare le eccezioni di cui sopra parlavamo. Possiamo quindi dire dello stesso individuo che, sebbene sia assolutamente soggetto alla legge della manifestazione vibratoria unicamente in rapporto alla sua manifestazione come tale, lo è solo relativamente in rapporto alla sua vita volontaria, in base a quella che possiamo chiamare "libero arbitrio". Sotto il primo profilo, l'uomo, come ogni essere o cosa, è, per dirla in linguaggio islamico, naturalmente musulmano ("sottomesso" o "rassegnato"), cioè con-forme ai principi universali o, in altre parole, alla Volontà divina; ma sotto il secondo aspetto, quello della libertà relativa dell'uomo, egli può non essere musulmano, e allora o è mushrik ("associatore") quando si considera reale quanto la Volontà divina, oppure kâfir ("infedele" o “negazionista”) quando si considera l'unica ragione reale e l'unica ragione sufficiente delle sue azioni. Questi due attributi ne-gativi di mushrik e kâfir riguardano anche, in una certa misura, ogni uomo e perfino ogni essere, senza che ciò implichi necessariamente che quell'essere è necessariamente caratterizzato da queste determinazioni; shirk (“associazione”) e kufr (“negazione”) corrispondono a tamas (“ignoranza” o “oscurità”) della dottrina induista, tawhîd (“unione” o “unificazione”) corrispondente quindi a sattva (“bontà”). » o “conformità”) e il rajas (“passione”) di questa stessa dottrina è implicito sia nel tawhîd, sia nello shirk o nel kufr; queste due tendenze sono, come gli “attributi” o guna degli indù, qualità inerenti alla sostanza primordiale stessa da cui procede ogni manifestazione.
L'uomo, poiché partecipa con la sua libertà individuale alla Libertà divina, rappresenta per l'intero Es-sere terreno e questo comprende tutti i regni della natura, il luogo centrale dove si realizza la possibili-tà di tale partecipazione, direttamente accrescitiva, alla Libertà o Indeterminazione divina, ciò spiega chiaramente il “diritto” che l'uomo ha sui regni della natura, “diritto” che entra in vigore anche nel sa-crificio.
La vita volontaria dell'uomo è, quindi, una manifestazione che, dal punto di vista umano, non si rego-la spontaneamente o per così dire "automaticamente", come avviene per ogni manifestazione mera-mente "passiva" o "fisica". Spetta all'uomo conformare la propria manifestazione, quindi la propria vita, alla Norma universale e divina ed è qui che entra in gioco per lui la Tradizione, e più particolar-mente questo elemento, centrale di un certo rispetto, che designiamo con il termine "sacrificio".
Possiamo considerare la Tradizione stessa come una sorta di “sacrificio” nei confronti della vita strettamente profana, che di per sé non comporta alcun elemento sovraindividuale; infatti ogni rito costituisce un'interruzione del flusso di questa vita e una sorta di morte rispetto ad essa. Ciò è visibile in modo particolarmente chiaro nel rituale islamico; la preghiera ripetuta cinque volte al giorno costituisce infatti un sacrificio dal punto di vista della vita puramente terrena e mondana, poiché la preghiera è una sorta di morte per questo mondo, proprio perché mette in gioco un elemento sovraindividuale che va oltre la vita e la contraddice in un certo senso. Detto questo arriveremo al sacrificio nel senso letterale ed immediato del termine. -
.
Questo articolo, apparso sulla revue di Etudes Traditionelle dell'aprile 1938, è citato da René Guénon nel capitolo su Caino e Abele nel "Regno della quantità e segni dei tempi" e non è uguale all'omonimo capitolo pubblicato nell'"Occhio del Cuore" dello stesso autore.
Il Sacrificio
F. Shuon
I.
La teoria del sacrificio è inseparabile da quella della manifestazione stessa, sia in senso ontologico che cosmologico del termine; per situare adeguatamente la questione, è necessario considerare soprattutto la manifestazione come un sacrificio, ossia il processo stesso della manifestazione. Possiamo sceglie-re, come esempio di questo sviluppo, una sua modalità particolare, cioè la manifestazione del suono, che è primordiale nell'ordine delle percezioni sensibili e vedremo in che modo essa simbolicamente tracci, allo stesso modo di qualsiasi altra modalità, il processo in questione. Infatti, per potersi pro-lungare nel tempo, il suono deve passare in qualche modo attraverso una serie di vibrazioni o, in altre parole, il suono può manifestarsi solo attraverso una sorta di arresti o lacune che in qualche modo lo estendono. Qui appare molto chiaramente la legge di compensazione insita in ogni manifestazione: considerare queste soste o questi vuoti come “sacrifici” rispetto alla manifestazione, di cui costituiscono tuttavia un elemento indispensabile, ci fa immediatamente comprendere in che modo il sacrificio è parte integrante della manifestazione e quale ruolo è chiamato a giocare: gioco inteso nel senso proprio del termine, vale a dire applicando l'idea che esprime all'ordine umano, individuale o sociale. Ritornando al nostro esempio del suono, aggiungeremo ancora che, se volessimo ignorare questo “vuoto” la cui applicazione all’ordine umano è il sacrificio, la manifestazione dovrebbe essere ridotta ad una sorta di esplosione istantanea che accentrerebbe in sé tutta la potenza o, se si vuole, tutta la vitalità del suono, potenza che, in condizioni normali, viene affermata proprio dalla forza e dalla durata del suono.
Il suono manifestato nel tempo può dunque essere considerato, rispetto al suono istantaneo di cui abbiamo appena provvisoriamente ipotizzato la possibilità, come la rifrazione spezzata di questo suono; e, parimenti, qualunque manifestazione, qualunque essa sia, implica tale rifrazione di un prototipo concepito in modalità “istantanea”. Non si può però dire che una manifestazione «istantanea» o «centrale» sia a tutti gli effetti un'impossibilità: si tratta piuttosto di una possibilità relativa nell'ambito del-la sua impossibilità, se è consentito esprimerla in questo modo, cioè per dire che si realizza simbolicamente nella manifestazione normale, per assumere un aspetto malefico o benefico ma la questione è troppo complessa per poterci soffermare ulteriormente e ci limiteremo a citare come rispettivi esempi quello del cataclisma e quello del miracolo.
Edited by amarisia - 17/12/2023, 21:21 -
.
Constatiamo inoltre che il nome di Eolo, "Aìolos", risulta molto simile, considerando l'abituale caduta della V, a quello del dio dei venti indù, chiamato "Vayu": questa coincidenza tra Omero ed il mondo mitologico indiano appare tanto più significativa, in quanto non resterà l'unica in cui ci imbatteremo nel corso di questa ricerca (si comincia altresì ad avvertire la sensazione che il "brodo primordiale" dei miti indoeuropei, sia omerici che nordici o indù, alluda ad un mondo originario caratterizzato da una dimensione più marinara che continentale). [tratto da Omero nel baltico di Felice Vinci] -
.
nuovo link al PDF in italiano -
.
Per il metafisico è inconcepibile che forme come questa, che esprimono una data dottrina con precisione matematica, possano essere state "inventate" senza conoscerne il significato. L'antropologo, è vero, crederà che tali significati siano semplicemente "letti nelle forme" da un simbolista sofisticato (si potrebbe anche fingere che una formula matematica possa essere stata scoperta per caso) ma il fatto che una spilla o un bottone da balia siano privi di significato e siano solo una comodità per noi, è semplicemente la prova della nostra profana ignoranza e del fatto che tali forme sono state "sempre più svuotate di contenuto nel loro cammino fino a noi" (Andrae). Lo studioso d'arte non sta "leggendo" in queste forme intelligibili un significato arbitrario ma semplicemente interpreta il loro significa-to, ha capito che questa è la loro "forma" o "vita" ed è presente in esse indipendentemente dal fatto che i singoli artisti di un dato periodo, o noi stessi, lo sappiamo o no. Nel caso di specie la prova che il significato del perno di sicurezza era stato compreso si può addurre nel fatto che le teste o gli occhi delle fibule preistoriche sono regolarmente decorate con un repertorio di simboli spiccatamente solari.
tratto da "la mentalità primitiva" -
.
Quelle che chiamiamo "invenzioni" non sono altro che l'applicazione di noti principi metafisici a fini pratici ed è per questo che la tradizione attribuisce sempre le invenzioni fondamentali a un eroe della cultura ancestrale (sempre, in ultima analisi, una discesa del Sole), cioè a una rivelazione primordiale.
In queste applicazioni, per quanto utilitaristiche fossero le finalità, non era assolutamente necessario sacrificare la chiarezza del significato originario della forma simbolica: al contrario, l'attitudine e la bellezza del manufatto esprimono e dipendono al tempo stesso dalla forma che sottende esso. Possiamo vederlo molto chiaramente, per esempio, nel caso di un'invenzione così antica come quella del-la "spilla di sicurezza", che è semplicemente un adattamento di un'invenzione ancora più antica, quel-la dello spillo o ago avente ad un'estremità una testa, anello o occhio e dall'altro una punta; una forma che, come "spillo" penetra direttamente e lega insieme i materiali, e come "ago" li lega insieme la-sciando dietro di sé come sua "traccia" un filo che nasce dalla sua cruna. Nella spilla da balia, il gambo originariamente diritto dello spillo o dell'ago è ripiegato su sé stesso in modo che la sua punta ripassi attraverso "l'occhio" e vi sia trattenuta saldamente, nello stesso tempo che fissa qualsiasi mate-riale sia penetrato.
Chi conosce il linguaggio tecnico del simbolismo iniziatico (in questo caso, il linguaggio dei "misteri minori" dei mestieri) riconoscerà subito che lo spillo o l'ago è un simbolo di generazione, e la spilla da balia un simbolo di rigenerazione. La spilla da balia è, d'altronde, l'equivalente del bottone, che lega insieme le cose ed è attaccato ad esse per mezzo di un filo che attraversa e ritorna nuovamente nei suoi fori, che corrispondono alla cruna dell'ago. Il significato dello spillo metallico, e quello del filo lasciato dall'ago (fissato o meno a un bottone che corrisponde alla cruna dell'ago) è lo stesso: è quello dello "spirito-filo" con cui il Sole collega a sé tutte le cose e le fissa; è il ricamatore e il sarto primordiale, dal quale il tessuto dell'universo, al quale le nostre vesti sono analoghe, è intessuto su un filo vivo. -
.Il giudizio universale mal si coniuga con la religione vedica, il giudizio fosse anche individuale prevede il credere in un Dio di vendetta piuché di giustizia, la religione vedica invece ci presenta un Dio di diversa natura, nel cui piano di evoluzione per l'uomo prevede la reincarnazione, come strumento a ciò che l'uomo si evolva e comprenda attraverso nuove esperienze il realizzare del sé, il giudizio invece tutto questo lo nega, io nonostante teologo credo nella reincarnazione, visto che molti padri ne hanno scritto a favore.
Questo post contiene un fraintendimento di comprensione e un errore fondamentale dal punto di vista tradizionale:
fraintendimento nel ritenere il Giudizio Universale come se fosse una sorta di processo in tribunale. Non lo è, è “solo” il bilancio finale di quel che è stato in questo ciclo di umanità: i pro, i contro, la compensazione degli sbilanciamenti ed, in ultimo, anche una valutazione dei singoli elementi della rosa umana ed in questo non è molto diverso dal concetto indiano di mahāpralaya.
Errore fondamentale, di cui si è già abbondantemente parlato anche in questo forum, è il concetto di reincarnazione come elaborato dalle correnti teosofiche ed occultiste del diciannovesimo secolo, che mal interpretarono il concetto di metempsicosi ereditato dalla filosofia classica. Per intendere bene il concetto di “stati molteplici dell’essere” bisognerebbe riuscire a superare l’ancoraggio della fisicità che ci lega a ridurre tutto a “questo mondo” e a questa umanità. Esiste molto più di questa realtà fisica che ci circonda, non scordiamolo. -
.
ota. - Illustrare completamente il saggio di cui sopra richiederebbe un ampio repertorio di esempi plastici, musicali e letterari scelti da molti paesi e molti periodi. Le riproduzioni sulle tavole allegate sono quindi scelte per illustrare un solo punto; che la bellezza non è determinata dal soggetto. Non è un potere dell'ethos, ma è trascendentale, al di là del bene e del male, sacro o profano; ed è comunicato attraverso la disposizione di linee e masse (forma, ritmo, pattern, fraseggio, economia di movimento) piuttosto che dalla rappresentazione. Allo stesso tempo, c'è questo legame con il soggetto, che la Bellezza non si raggiunge se il soggetto non è "sentito" appassionatamente. 


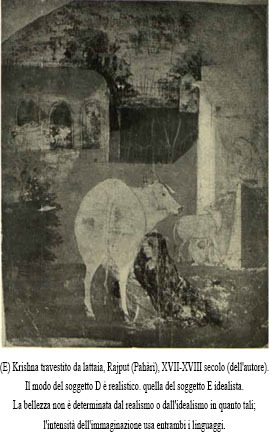
-
.
Ristampato da "The Burlington Magazine" .Aprile 1915.
"LA BELLEZZA È UNO STATO"
Di Ananda Coomaraswamy
L’idea che oggetti naturali come esseri umani, animali o paesaggi, oppure oggetti artificiali come fabbriche, tessuti o opere d'arte intenzionale, possano essere classificati come belli o brutti È generalmente molto diffusa. Eppure non è mai stato trovato un principio generale di classificazione: e quello che sembra essere bello per uno è descritto come brutto da un altro. Nelle parole di Platone "Ognuno sceglie il suo amore dagli oggetti di bellezza secondo il proprio gusto".
Prendiamo, ad esempio, il tipo umano: ogni razza, e in una certa misura ogni individuo, ha un ideale unico. Non possiamo sperare in un accordo definitivo: non possiamo aspettarci che l'europeo preferisca le fattezze mongole, né il mongolo l'europeo. Certo, è più facile che ciascuno mantenga il valore assoluto del proprio gusto e giudichi gli altri tipi come brutti; proprio come l'eroe della cavalleria sostiene con la forza delle armi che la sua amata è molto più bella di qualsiasi altra, allo stesso modo ogni setta è convinta del valore assoluto della propria etica ma è chiaro che queste affermazioni non sono altro che dichiarazioni di pregiudizio, perché chi può decidere quale ideale razziale o morale sia meglio?
È un po’ troppo facile decidere che il nostro sia meglio: al massimo abbiamo il diritto di crederlo il migliore per noi. Questa relatività non è suggerita in nessun modo migliore che nel detto classico attribuito a Majnūn, quando gli fu fatto notare che il mondo, in generale, considerava la sua Lailā tutt'altro che bella. Lailā ", lui rispose “richiede gli occhi di Majnūn.”
La stessa cosa con le opere d'arte. Diversi artisti sono ispirati da diversi oggetti; ciò che è attraente e stimolante per uno è deprimente e poco attraente per un altro, pure la scelta varia da popolo a popolo e da epoca a epoca però l'apprezzamento di tali opere è identico anche se, tutti gli uomini, generalmente, ammirano solo le opere che per educazione o temperamento sono predisposti ad ammirare.
Entrare nello spirito di un'arte sconosciuta richiede uno sforzo maggiore di quanto la maggior parte sia disposta a fare. Lo studioso classico è totalmente convinto che l'arte della Grecia non sia mai stata eguagliata o superata e mai lo sarà; ci sono molti che pensano, come Michelangelo che, poiché la pittura italiana è buona, la buona pittura sia solo italiana. Ci sono molti che non hanno ancora provato la bellezza della scultura egizia o della pittura o della musica cinese o indiana e che siano pure renitenti a negare queste bellezze non prova nulla.
È pure possibile dimenticare che certe opere siano belle: il Settecento aveva così dimenticato la bellezza della scultura gotica e della primitiva pittura italiana che il ricordo della loro bellezza fu restaurato solo con un grande sforzo nel corso dell'Ottocento. Possono pure esistere oggetti naturali o opere d'arte che l'umanità impara solo molto lentamente a considerare come, in un qualche modo, siano belle; l'apprezzamento estetico occidentale del deserto e del paesaggio montano, ad esempio, non è più antico del XIX secolo ed è noto che gli artisti di alto rango spesso non vengano compresi fino a molto tempo dopo la loro morte.
Più consideriamo la varietà dell'elezione umana, più dobbiamo ammettere la relatività del gusto.
Eppure ci sono filosofi fermamente convinti che esista una Bellezza assoluta (rasa)(1) , proprio come altri sostengono le concezioni di Bontà assoluta e Verità assoluta. Gli amanti di Dio (Brahma) identificano questi assoluti con Lui (o Esso) e sostengono che Egli può essere conosciuto solo come Bellezza Perfetta, Amore e Verità. È anche ampiamente affermato che il vero critico (rasika) è in grado di decidere che le opere d'arte sono belle (ŗasavant) o che non lo siano, o in parole più semplici, sia capace di distinguere le opere d'arte autentiche da quelle che non hanno alcuna pretesa di essere così definite. Aderisco al punto di vista di questi pensatori e amatori ma allo stesso tempo ammetto liberamente la relatività del gusto, così come il fatto che tutti gli dei (deva e Īśvara) siano modellati a somiglianza degli uomini.
Resta, quindi, da risolvere questa apparente contraddizione.
Cosa che si può ottenere solo mediante l'uso di una terminologia più precisa.
Finora ho parlato di Bellezza senza definire il mio significato e ho usato una parola per esprimere una molteplicità di idee. Non intendo la stessa cosa quando parlo di una bella ragazza e di una bella poesia ed è ancora più ovvio che intendiamo cose diverse quando parliamo di bel tempo o di una bella foto.
In effetti, la concezione di Bellezza e l'aggettivo "bello" appartengono esclusivamente all'estetica e devono essere usati solo nel «giudizio estetico».
Raramente esprimiamo un giudizio simile quando parliamo di oggetti naturali definendoli belli; generalmente intendiamo dire che oggetti che definiamo belli ci sono congeniali, praticamente o eticamente. Troppo spesso fingiamo di giudicare un'opera d'arte allo stesso modo, definendola bella se rappresenta una qualche forma o attività che approviamo di cuore o se ci attrae per la tenerezza o l'allegria del suo colore, la dolcezza dei suoi suoni o il fascino del suo movimento ma quando esprimiamo così un giudizio sulla danza in accordo con il nostro atteggiamento simpatico verso il fascino o l'abilità del ballerino, o il significato della danza, non dovremmo usare il linguaggio dell'estetica.
Solo quando giudichiamo esteticamente un'opera d'arte possiamo parlare della presenza o dell'assenza di bellezza, possiamo chiamare l'opera rasavant o altrimenti; ma quando la giudichiamo dal punto di vista dell'attività, pratica o etica, dovremmo usare una terminologia corrispondente, chiamando il film, la canzone o l'attore "adorabile", cioè amabile, o altrimenti, l'azione "nobile", il Colore "brillante", il gesto "aggraziato", o altro, e così via e si vedrà che nel fare questo non stiamo realmente giudicando l'opera d'arte in quanto tale, ma solo il materiale e le parti separate di cui è fatto.
Naturalmente, quando si arriva a scegliere le opere d'arte con cui convivere, non c'è motivo per cui non dovremmo permettere che le considerazioni simpatiche ed etiche influenzino il nostro giudizio: perché l'asceta dovrebbe invitare il fastidio appendendo nella sua cella qualche rappresentazione di nudo, o il generale scegliere una ninna nanna da eseguire alla vigilia della battaglia? Quando ogni asceta e ogni di soldato diventerà un artista non ci sarà più bisogno di opere d'arte: nel frattempo una selezione etica di qualche tipo è lecita e necessaria ma, in questa selezione, dobbiamo capire chiaramente cosa stiamo facendo, se vogliamo evitare un'infinità di errori che culminano in quel tipo di sentimentalismo che considera essenziale, nelle opere d'arte, gli elementi utili, stimolanti e morali.
Non dobbiamo dimenticare che colui che interpreta il cattivo dell'opera può essere un artista più grande di colui che interpreta l'eroe. Perché la Bellezza, nelle profonde parole di Millet, non nasce dal soggetto di un'opera d'arte, ma dalla necessità che si è sentita di rappresentare quel soggetto.
Possiamo definire un'opera d'arte buona o cattiva solo riferendoci alla sua qualità estetica, poiché in quanto opera d'arte non sostiene alcuna attività, solo il soggetto e il materiale dell'opera sono invischiati nella relatività. In altre parole, dire che un'opera d'arte è più o meno bella, o rasavant, significa definire fino a che punto è un'opera d'arte, piuttosto che una mera illustrazione. Per quanto importante possa essere l'elemento di magia simpatica in un'opera del genere, per quanto importanti siano le sue applicazioni pratiche, non è in queste che consiste la sua bellezza.
Cos'è dunque la Bellezza, cos'è il rasa, cos'è che ci autorizza a parlare di alcune opere come belle o rasavant? Qual è questa unica qualità che hanno in comune le opere d'arte più dissimili?
Ricordiamo la storia di un'opera d'arte.
(1) C'è un'intuizione estetica da parte dell'artista originale, - il poeta o il creatore;
(2) poi l'espressione interna di questa intuizione, - la vera creazione o visione interiore della bellezza,
(3) l'indicazione di ciò mediante segni esterni (linguaggio, suono, pittura, gesto) a scopo di comunicazione,
l'attività tecnica;
(4) e infine, il risultato con la stimolazione del critico o rasika alla riproduzione dell'intuizione originale, o di una qualche approssimazione ad essa.
La fonte dell'intuizione originale può, come abbiamo visto, essere qualsiasi aspetto della vita.
A un creatore le squame di un pesce suggeriscono un disegno ritmico, un altro è mosso da certi paesaggi, un terzo sceglie di parlare di baracche, un quarto di cantare i palazzi, un quinto può esprimere l'idea che tutte le cose siano intrecciate, intessute e innamorate in termini di Danza Generale, oppure può esprimere la stessa idea in modo altrettanto vivido dicendo che "non un passero cade a terra senza che nostro Signore lo sappia".
Ogni artista scopre la Bellezza, e ogni critico la ritrova quando assapora la stessa esperienza attraverso i segni esterni. Ma dov'è questa bellezza?
Abbiamo visto che non si può dire che esista in certe cose e non in altre.
Si può allora affermare che la Bellezza esista ovunque e questo non lo nego, anche se preferisco un'affermazione più chiara: “che possa essere scoperta ovunque”.
Se si potesse dire che esiste dappertutto in senso materiale e intrinseco, potremmo cercarla con le nostre macchine fotografiche e misurarla, alla moda degli psicologi sperimentali: ma se lo facessimo, potremmo raggiungere solo una certa conoscenza del gusto medio e non dovremmo scoprire un mezzo per distinguere le forme belle da quelle brutte.
La bellezza non può mai essere misurata in questo modo, perché non esiste separatamente dall'artista stesso e dal rasika che entra nella sua esperienza.
Tutta l'architettura è ciò che fai quando la guardi.
Pensavi che fosse nella pietra bianca o grigia? o nelle linee di archi e cornici?
Tutta la musica è ciò che si risveglia in te quando gli strumenti te lo ricordano.
Non è il violino né le cornette... e nemmeno la partitura del baritono
È sempre più vicino e più lontano di loro.
La visione della Bellezza è spontanea, proprio come la luce interiore dell'amante (bhakta).
È uno stato di grazia che non può essere raggiunto con uno sforzo deliberato; anche se forse potremmo rimuovere gli ostacoli alla sua manifestazione, perché ci sono molti testimoni che il segreto di tutta l'arte si trova nell'oblio di sé. E sappiamo che questo stato di grazia non si ottiene nella ricerca del piacere; in verità gli edonisti hanno la loro ricompensa, ma sono schiavi della bellezza, mentre l'artista è libero nella Bellezza. È inoltre da osservare che quando parliamo seriamente di opere d'arte come belle, nel senso che sono veramente opere d'arte, valutate come tali a parte il soggetto, l'associazione o il fascino tecnico, parliamo ancora in modo ellittico.
Intendiamo dire che i segni esterni - poesie, immagini, danze e così via - sono promemoria efficaci. Possiamo dire che possiedono una forma significativa ma questo può solo significare che possiedono quel tipo di forma che ci ricorda la Bellezza e risveglia in noi l'emozione estetica. La spiegazione più vicina della forma significativa dovrebbe essere quella forma che mostra le relazioni interiori delle cose; o, dopo Hsie Ho,
""Che svela il ritmo dello spirito nei gesti degli esseri viventi".
Tutte le opere che possiedono una forma significativa sono linguistiche e, se lo ricordiamo, non cadremo nell'errore di coloro che sostengono l'uso del linguaggio fine a se stesso, né confonderemo le forme significative, o il loro significato logico o valore morale, con la Bellezza che ci ricordano.
Il vero critico (rasika) percepisce la Bellezza di cui l'artista ha esibito i segni. Non è necessario che il critico apprezzi il significato dell'artista - ogni opera d'arte è un kāma-dhenū, che fornisce molti significati - perché sa senza ragionare se l'opera è bella o meno, prima che la mente cominci a chiedersi di cosa si tratta.
Gli scrittori indù affermano che la capacità di sentire la bellezza (di gustare il rasa) non può essere acquisita con lo studio, ma è la ricompensa di meriti ottenuti in una vita passata; poiché molti bravi uomini e aspiranti storici dell'arte non l'hanno mai percepito. Il poeta è nato, non creato; ma lo è anche il rasika, il cui genio differisce in grado, non in natura, da quello dell'artista originale.
Nella fraseologia occidentale potremmo esprimerci dicendo che l'esperienza può essere acquisita solo dall'esperienza; le opinioni devono essere guadagnate, non otteniamo e non sentiamo nulla se ci assumiamo l'autorità di affermare che un’opera particolare sia bella. È molto meglio essere onesti e ammettere che forse non possiamo vederne la bellezza. Potrebbe venire un giorno in cui saremo meglio preparati.
Il critico, non appena diventa sostenitore, deve dimostrare la sua tesi e non può farlo con un processo di discussione ma solo creando una nuova opera d'arte: la critica. Il suo pubblico coglie il bagliore di seconda mano - ma sempre lo stesso, perché ce n'è solo uno – e ha quindi l'opportunità di avvicinarsi all'opera originale una seconda volta, con più riverenza.
Quando dico che le opere d'arte ricordano e che l'attività del critico è una riproduzione, suggerisco che anche la visione dell'artista originale può essere più una scoperta che una creazione.
Se la Bellezza attende dappertutto la scoperta, vale a dire che attende il nostro ricordo (nel senso Sūfì e in quello di Wordsworth): nella contemplazione estetica (rasāsvādana) come nell'amore (bhakti) e nella conoscenza (vidyā), recuperiamo momentaneamente l’unità del sé con il Sé, della nostra individualità con ‘Oh!’ “Ωυ”.
Non ci sono gradi di bellezza; sia l'espressione più complessa che quella più semplice ci ricordano lo stesso stato. Una sonata non può essere più bella della lirica più semplice, né il dipinto più bello di un disegno solo per una maggiore elaborazione. L'arte civilizzata non è più bella dell'arte selvaggia, semplicemente è forse più attraente. Vagliamo un'analogia matematica: se consideriamo cerchi grandi e piccoli, questi differiscono solo nel loro contenuto, non nella loro circolarità. Allo stesso modo, non può esserci alcun progresso continuo nell'arte. Una data intuizione raggiuge immediatamente un'espressione perfettamente chiara e non resta che moltiplicare e ripetere questa espressione. Questa ripetizione può essere desiderabile per molte ragioni, ma quasi invariabilmente implica una graduale decadenza, perché presto iniziamo a dare l'esperienza per scontata.
La vitalità di una tradizione persiste solo finché è alimentata dall'intensità dell'immaginazione.
Ciò che intendiamo per arte creativa, tuttavia, non ha alcun legame necessario con la novità del soggetto, sebbene ciò non sia escluso. L'arte creativa è l'arte che rivela la Bellezza dove avremmo dovuto altrimenti trascurarla. La bellezza a volte viene trascurata solo perché certe espressioni sono diventate ciò che definiamo "banale"; poi l'artista creativo che ha a che fare con lo stesso soggetto ci restituisce la memoria. L'artista è sfidato a rivelare la bellezza di tutte le esperienze, nuove e vecchie.
Molti hanno giustamente insistito sul fatto che la bellezza di un'opera d'arte sia indipendente dal suo soggetto e, in verità, l'umiltà dell'arte, che trova ovunque la sua ispirazione, è identica all'umiltà dell'Amore, che riguarda allo stesso modo un cane e un Brahmano - e all'umiltà della scienza, per la quale la forma più bassa è significativa quanto la più alta. Questo è possibile, perché è lo stesso Brahman indiviso - nostro Padre - che è in ogni forma di vita, la più piccola e la più grande, dal minerale all'uomo e dall'uomo al cosmo.
Con la varietà del suo materiale l'artista ci ricorda che Tutto è in tutto: e, "Se vediamo una bella forma", è il riflesso divino che risplende.
Si vedrà ora in che senso siamo giustificati nel parlare della Bellezza Assoluta e nell'identificare questa Bellezza con Dio. Con questo non implichiamo che Dio abbia una bella forma che possa essere oggetto di conoscenza ma che quando vediamo e sentiamo la Bellezza, vediamo e siamo Dio. Che Dio sia il primo artista non significa che abbia creato belle forme, che avrebbero potuto non essere belle se fosse scivolata la mano del vasaio: ma ogni oggetto naturale è una realizzazione immediata del suo essere. Questa attività creativa è paragonabile all'espressione estetica nel suo carattere non volitivo, nessun elemento di scelta entra in quel mondo di immaginazione ed eternità ma c'è sempre un'identità perfetta di espressione di intuizione, anima e corpo. L'artista umano che scopre la Bellezza qua o là è il guru ideale di Kabir, che «rivela lo Spirito Supremo ovunque la mente si attacca».
La bellezza è una delle tre attività o stati spirituali, in cui l'uomo si libera da se stesso e diventa Dio. Questi stati celesti non costituiscono una persona ma là dove si trovano è il Regno dei Cieli, soggettivo e indiviso. La bellezza non è che un nome del Tao, i cui altri nomi sono Amore Assoluto e Verità Assoluta o Realtà. Questi nomi, tuttavia, non sono predicati, ma promemoria di esperienza.
Quando sappiamo che «Dio è uno spirito» e deve essere adorato in spirito, quando viene ingiunto Devam bhutvā devam yajet (Adorare Dio diventando Dio), è implicitamente la stessa cosa di quando diciamo che la Bellezza nasce - ci è nota, o adorata da noi, – solo quando viene percepita. Rasa rasāsvādana.
Rasa non è altro che la degustazione di rasa. Non c'è altra Bellezza, nessun altro Amore, nessun'altra Verità che la Bellezza, l'Amore e la Verità nei nostri cuori.
(1) Rasa, rasavant e rasika sono i termini principali dell'estetica indiana che è stata elaborata in modo molto completo relativamente al dramma e alla letteratura. L'opera più importante disponibile è la Sāhitya Darpana di Visvanātha, pubblicata con traduzione nella Bibliotheca Indica, 1851. Vedi anche Regnaud La Rhetorique Sanskrite. 1884.
"Il segreto dell'arte sta nell'artista stesso" - Kuo Jo-hsū 12th century, citato in The Kokka, No.244 -
.
Mahā-Pralaya e Giudizio Universale
Ananda K, Coomaraswamy
La tradizione vedica prevede il viaggio (yāna) dell'individuo dopo la morte come un passaggio da un piano dell'essere (loka) a un altro e, sebbene esista la possibilità della perpetuità (sthāyitā) su qualsiasi piano dato fino alla Fine dei Tempi (kalpānta, mahā-pralaya), non esiste alcuna concezione della possibilità di un ritorno a uno stato passato. La dottrina della reincarnazione, in cui è concepita la possibilità di un ritorno a una condizione precedente, riflette una tendenza edificante dell’estensione religiosa (bhakti-vada) e psi-cologica (hīnayāna), che incorpora elementi popolari non vedici.1
Più esattamente, ci sono due diverse vie che possono essere seguite: l'Angelica (dēvayāna) nel caso dell'individuo il cui trasporto è per la Conoscenza, e Patriarcale (pitṛyāna) nel caso in cui il trasporto è per le Opere (karma) fatte allo scopo di ricompensa. Nel primo caso l'individuo passa attraverso il "Sole" e quindi torna al Sé Supremo e alla Non-Terra: nel secondo, raggiunge solo la "Luna" e, a tempo debito, ritorna a un nuovo stato corporeo in un successivo sotto-periodo (manvantara), quando si ripresenta la scelta dei percorsi. Quanto segue qui, tuttavia, non tiene conto di questa distinzione di rotte ma piuttosto della distinzione tra coloro che da un lato sono sostenuti o dalla Comprensione o dalle Opere, essendo ugualmente Viandanti e quelli, dall'altra, che non hanno né compreso né ancora operato e che il Giudizio Universale trova non solo non annientati ma anche privi di merito.
In ogni caso, la fine del viaggio è sulla riva più lontana del mare della vita (saṃsarā). Quando si approda in quel luogo, Jīvātman conosce se stesso come Paramātman e lo spazio-assoluto-nel-cuore (antarhŗdaya ākāśa) è noto come il corpo-spazio-assoluto (ākāśa-śarīra) dell'Essere e del Non-Essere, il mare della vita è come contro-visto (paryapaśyata) dalla propria identità.ii
Viaggiando, ci vengono date indicazioni su quel Paradiso (prāṇārāma, nandana), sull’Unione (sāyujya samādhi), sul pensiero che consuma (dhyāna), sull’Estasi (ānanda), sulla Volontà che consuma (kāma) e sul consenso (sāhitya) dell'Arte (nirmāṇa): conoscenza, amore e lavoro diventano puro (asakta) Atto. Ma sebbene la possibilità di una liberazione graduale (krama-mukti) sia aperta al Viaggiatore,iii c'è anche la possi-bilità, per colui la cui nave è senza timone o governata in modo errato, di vagare su rotte inesplorate verso un approdo sconosciuto, sempre più lontano dal Molo (ghāţ): così lontano e così a lungo che potrebbe non essere in vista dell’Altra Riva quando ogni costa e ogni nave si dissolveranno alla fine dei tempi. Quindi alla Fine dei Tempi c'è una dipartita del Liberato (mukta) e dal vincolo dell'Ego (māna-baddhaka). Nella tradizione cristiana questo è chiamato il Giudizio Universale.
Salvo e ad eccezione dei Deva più elevati, gli Angeli (ājānaja), il cui essere proviene dall'Eternità, tutti gli esseri, siano essi "svegli o morti", sono "giudicati" in questo Ultimo giorno. Il Sé di coloro che hanno già raggiunto una Totale (nirguṇa) Realizzazione (muktī) è già in identità cosciente con l'Identità Suprema: ora, per coloro la cui Realizzazione è stata “per gradi” (krama) o qualificata (saguṇa) segue l’ultima morte dell'Ego assoluto, una "morte" che è assolutamente Mors janua vitae,* un'affrancatura da ogni possibile contingenza: le porte del paradiso vengono aperte al Jīvātman, ora Kŗtātman, "Sé perfezionato", in modo che diventi di nuovo (abhisambharati) nella sua stessa forma (sva-rūpa), senza immagine (nirābhāsa), pura intelligenza (cit) e pura delizia (pūrnānanda). Gli esseri perduti, che nel tempo non hanno raggiunto nemmeno una realizzazione parziale ma sono ancora del tutto coinvolti nella rete dell'illusione (moha-kalila), ritenendo che l'Ego sia il Sé, per loro non può esserci alcuna possibilità di Affrancamento alla fine del Tempo. Coloro che hanno pensato e pensano ancora, che agire "per il bene del Sé" (Bŗhadāraņīyaka Upaniṣad, II, 4, 5) non significhi altro che soddisfare ogni desiderio dell'Ego, servendo il corpo qui e ora, vivendo come tali "Asura Upaniṣad", questi "periranno", (Chāndogya Upaniṣad, VIII, 8). Questi sono i "dannati". La loro dannazione è una condanna da sé-giudicata e da Sé-giudicata a una latenza infinita, sebbene non eterna, un annichilimento relativo, sebbene non assoluto: a un Inferno sotto il silenzioso mare vitreo del non-Tempo (kilpāntara) che divide il Tempo dal Tempo, lì per Necessità, "giustizia di
Dio", per attendere la loro mortale rinascita in un altro Tempo (kalpa), dove si presenterà di nuovo la possibilità di ottenere o non ottenere un'affrancatura immediata o differita.
Abhimānatva,** quindi, è il "Peccato Originale", la pretesa di Satana di un "uguaglianza con Dio", la sua affermazione dell'indipendenza e dell'auto-sussistenza dell'Ego è l'occasione della sua Caduta e di coloro che lo seguono. La caduta dell'uomo, la stessa in genere, è stata tradizionalmente descritta come un man-giare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Questo Albero non è altro che l'Albero della Vita, piantato dal Sé, da Dio stesso, nel Giardino della Vita (prāṇārāma), come una cosa bella e una delizia degli occhi, per il piacere suo e dell'uomo ma mangiare quel frutto è peccato mortale (anṛta) contro lo Spirito, "proibito" all'uomo come ego individuale:iv perché il "mangiare" simbolizza un'assimilazione e un'autoidentificazione con le cose "come sono in se stesse", non "come sono in Dio", quindi un'assun-zione di ciò che è nulla in sé, un veleno (viṣa)v che è la Morte dal punto di vista della Vita Eterna, una chiusura delle Porte del Paradiso.
Nessuno tranne il Sé può ingoiare un tale veleno e tuttavia vivere, come fa Shiva quando, mediante altre immagini, beve il dvandva, doppio-tormento [veleno] che viene prodotto dalla Zangolatura dell’Oceano di Latte; la ferita e i segni di questa rovina sono la macchia nero-bluastra sulla Sua gola come Nīlakanţha, Vişakanţha, Viṣagnipā, il Suo portarsi il Serpente al petto come nāga-yajñōparita e la Sua “dipendenza” dalla droga. Quell'apparente sottomissione del Sé alla tragedia (anŗta, arta) della Vita, quel dolore accettato, è la Passione di Dio e di tutti gli uomini.vi
1 A.K. Coom. Yakşas, I, p. 14, nota 1.
ii Pañcaviṃśa Brāhmana, VII, 8, 1; Sańkarācārya, Svātmanirūṇa, 95: "Sulla vasta tela del Sé, l'immagine dei molteplici mondi è dipinta dallo stesso Sé e quel Sé Supremo ne trae una grande gioia."
iii I concetti di yana e krama-mukti implicano per ipotesi un attraversamento del mare della vita (saṃsara), se le Upanişad contemplano anche la possibilità di un Affrancamento Immediato e la conseguente Trasformazione (abhisambhava o parāvtitti), la realizzazione: "Io sono Brahman", "Che tu sia nell'esperienza reale”, questo taglio dei nodi del cuore in un colpo solo non è il nostro tema attuale.
* "La morte è la porta della vita"
** orgoglio; egoismo; pregiudizio.
iv Non si deve pensare che, poiché l'uomo è rappresentato come se soccombesse alla seduzione della donna, sia implicita una caduta puramente carnale. Qui "uomo" sta per "Soggetto" e "donna" per "Oggetto" (in ogni caso un’immagine o un simbolo, skr. pratīka,); la Caduta è ugualmente una deroga dell'Intelletto e della Volontà.
v È impossibile non vedere una connessione tra viṣa “veleno”, con l'oggettività viṣayatā; cfr. Maitrī Upaniṣad, VI, 31, dove si dice che la visione «si nutre di» apsaras (cioè affascinanti possibilità di essere) come oggetti dei sensi (vişayāny; anche Nirukta, V, 15, dove apsaras è artificialmente connesso con a-psa, dando il senso di "cibo proibito"; Bŗhāddevatā, V, 148 e 149, e Sarvānukramanī, I, 166, dove Mitra-Varuna sono sedotti dalla vista di Urvaśī,
vi "Quel cuore che si distingue dal dolore e dalla sofferenza,//Né il sigillo né la firma dell'amore possono conoscere".(Sanā'I) -
.
DEVA
Nomi personali come Śiva o Vişņu, quando applicati a Īśvara (cioè Saguņa Brahman, l'Ātman), sono solo termini sanscrito equivalenti al termine "Dio" nel senso cristiano mentre Nirguṇa Brahman è la Divinità. Poiché Īśvara può manifestarsi anche come un Deva, un Bhūta, uno Yakşa, un Asura, ecc., sebbene sia il maggiore in ciascuna di queste classi (come spesso indicato dal prefisso Mahā, "Grande", come in Mahādeva) e dato che ciascuna di queste designazioni generiche può essere applicata a una varietà indefinita di stati dell'essere nei "Tre Mondi", è affiorata la nozione diffusa di un politeismo indù.
Allo stesso modo, dal punto di vista islamico la Trinità cristiana rappresenta un politeismo, sebbene questa sia un'interpretazione errata.1
Ugualmente un cristiano può dire, come dice infatti Meister Eckhart, che Dio è "Essere" ma allo stesso tempo deve parlare di altri "esseri" di ogni tipo senza capire che Dio è semplicemente un essere tra gli altri, forse inferiore o uguale agli altri, così, in termini vedici Deva, ecc., sono un’unità e una gerarchia date per scontate. Anche all'interno del cristianesimo si è discusso sull'opportunità di dire se Dio sia un Angelo ed è stata raggiunta la conclusione generale che si tratta più di una questione di convenienza che di fede, dal momento che “l’Angelo del grande consiglio” di Isaia 9.6, versione Settanta, presumibilmente si riferisce a Dio; cfr. L'espressione di Meister Eckhart "Primo Angelo" equivale all’ "Angelo Unico" della Bŗhadāraņīyaka Upanişad I.2.7.
La traduzione usuale e indiscriminata di Deva come 'Dio' o 'dio', sebbene debba in parte riferirsi a idee preconcette che presuppongono il politeismo pagano, ha anche una sanzione etimologica e fornisce un buon esempio del tipo di errore che può derivare da un dipendenza involontaria da quella che è una corretta derivazione scientifica, infatti, la parola Deva corrisponde al latino deus, al termine divinità, dio, ecc., anche se si sarebbe potuto tenere conto del fatto che, come il daeva dell’avesta, anche nel sanscrito deva non denota sempre con precisione "Dio".
Deva è letteralmente "lo Splendente"; la traduzione più appropriata è "Angelo" e i Deva più elevati sono principi o intelligenze pure o "Eoni", la cui "brillantezza" (prabhā, prakāśa), rappresentata nell'arte come un nimbo o come raggi, si riflette nelle possibilità dell'esistenza (Māyā o Āpah, le Acque) come attualità, cioè esistenza. Secondo la loro gerarchia, Deva e Devata sono chiamati i "membri" (añga) del Brahman, o gli "attributi" (bhakti) o "poteri" (vibhuti) dell'Ātman - allo stesso modo gli angeli cristiani, nelle loro gerarchie e ordini sono i ministri, i poteri e i messaggeri di Dio.
La corrispondenza si estende così lontano che, nello stesso modo in cui troviamo nella tradizione indiana le dimore e i veicoli (āsana, vāhana) o gli attributi e le armi (āyudha puruşa, ecc.) dei Deva, incluso Īśvara, descritti e rappresentati iconograficamente come Deva, anche le gerarchie cristiane includono nel coro più alto un ordine di "Troni", e nel secondo un ordine di "Dominazioni" e nello stesso modo in cui la virtù delle Dominazioni è «imporre l'ordine secondo la Volontà di Dio a coloro che sono loro soggetti» per «costringere gli spiriti maligni» e così via, così anche gli Āyudha Puruşas dei Deva Indiani appaiono al loro comando e sono il mezzo con cui si compie la loro volontà.
Angeli e Arcangeli sono ordini nel coro più basso, le cui funzioni sono più chiaramente legate alla vita umana, da dove vengono inviati come messaggeri agli uomini, o agiscono come guardiani regionali o individuali, per i quali esistono abbondanti paralleli nella tradizione dell’India, paralleli che arrivano fino all'esistenza di guardiani individuali (ārakkha devatā).
La tradizione vedica e la tradizione cristiana concordano anche per quanto riguarda l'indipendenza degli angeli nel movimento locale. Infine, anche se spesso si dice che il numero dei Deva è trentatremila e quello degli angeli sia incalcolabile, le parole di San Tommaso «questo non vuol dire che questo sia il numero preciso degli angeli» possono essere applicate ad entrambi i casi.2
Inoltre, quando si dice che come individui i Deva sono immortali (amara), questo si riferisce alla loro perpetuità su un dato piano dell'essere (loka) non soggetti a nessun successivo cambiamento di stato (punar mŗtyu), cioè non soggetto a non "morire di nuovo"3 nel corso del Tempo, sebbene ciò non escluda il ritorno naturale del loro essere al Brahman alla fine del Tempo (kalpanta),4 che è certamente un tipo di morte, ma nel senso assoluto, cioè nel senso di mors janua vitae.5
I Deva sono anche chiamati immortali, non come individui, ma per la stazione (sthāṇa) che occupano e questo si riferisce alla loro eternità come principi, come quando diciamo che in un'altra epoca un altro individuo diverso dall'attuale Indra occuperà il trono di Indra.
Da questo punto di vista nel Pañcavimśa Brāhmana VI.9.15 ss. i Deva sono definiti come una prima emanazione (prathamam asŗgram), come una pronuncia permanente (sthita vyāhŗtih), e in questo senso sono in contrasto con le esistenze individuali (mānuşyāh, gli uomini, i "mortali") la cui esistenza è «oggi giorno» (svah, svah). In totale accordo con questo, san Gregorio e sant'Agostino affermano "angelus nomen est officii, non naturae" e proprio come alcuni dei Deva superiori non sono influenzati dalla fine dei tempi, allo stesso modo:
«gli ordini angelici... secondo la differenza di grazia e natura. rimarranno sempre ma, quanto riguarda lo svolgimento degli uffici angelici, rimarrà in una certa misura e in una certa misura cesserà nel Giorno del Giudizio (San Tommaso, Summa Theologica I.Q.108, A.7).
Inoltre, nello stesso modo in cui i defunti sono in parte descritti come Deva (e questo è uno dei motivi specifici per cui la traduzione di Deva come "Dio" o "dio" è impropria), così anche «gli uomini possono meritare gloria a tal punto da essere uguali agli angeli, in ciascuno dei gradi angelici; e questo implica che gli uomini siano elevati agli ordini degli angeli» (San Tommaso, Summa Theologica I.Q.108, A-8).
È stato sufficientemente dimostrato da un confronto dettagliato delle nozioni corrispondenti alla natura e alle funzioni dei Deva e degli Angeli, che la traduzione di Deva come "Dio" o "dio"6 (la resa del termine come "dio" , significa più o meno "falso dio") è legittima solo quando il Deva in questione, espressamente o implicitamente, è il Deva più elevato e che in tutti, o in quasi tutti gli altri casi, è meglio usare la parola "Angelo". Lo stesso varrà per Yakşa nella maggior parte dei contesti, con la distinzione che gli Yakşa, sebbene di un'unica gerarchia, sono di ordini molto diversi, alcuni sono fate o elfi piuttosto che angeli; quindi, in questo caso, è generalmente meglio mantenere la parola originale. Quando Deva e Asura appaiono insieme, lo stesso termine generico deve essere applicato a entrambi (nello stesso modo in cui Michele e Satana sono ugualmente "Angeli") o, se si vuole fare una distinzione, allora Asura deve essere tradotto come "Angelo Oscuro" o meglio come "Daimon". Resta da sottolineare che Viśve Devatāh, i "Diversi Angeli", generalmente significano (ad esempio Bŗhād Devatā I.69 ss.) le tre Persone della Trinità (tridhā). Ma come dice il Eckhart (II, 153) "le schiere degli angeli sono innumerevoli", ma "per chi conosce la distinzione, a parte il tempo, il numero cento è uguale a uno".
1 Si può perfettamente comprendere perché i dottori islamici potessero interpretare erroneamente la dottrina della Trinità come politeismo, se si considerano affermazioni come quella di San Tommaso "Non diciamo l'unico Dio, poiché la Divinità è comune a più" (Summa Theologica IQ31, X.2). E ciò che è più notevole, "I santi sono chiamati dei per partecipazione", San Tommaso, Summa Theologica I.Q.108, A.5. Gli studiosi di indologia avrebbero dovuto considerare questo, prima di dare per scontato il "politeismo" o di inventare il "kathenonismo".
2 I riferimenti per tutte le dichiarazioni nel paragrafo seguente sono: Yāska, Nirukta VII.5; Bŗhāddevatā I.70, 71, 73, 74 e 98; Bŗhadāraņīyaka Upanişad III.9; Taittirīya Upanişad I.5, angānyanya devatāh; il libro Yakşas di A:K:Coomaraswamy, parte I e II; San Tommaso, Summa Theologica I.Q.107, A.4; idem, Q.108, A.5-7; idem, Q.112, A.4; e idem Q.113, A.1.
3 La tradizione vedica considera il viaggio (yana) dell'individuo dopo la morte come un passaggio da un piano dell'essere ad un altro, con la possibilità di perpetuità su un dato piano fino alla fine dei tempi e con un ritorno all'incarnazione in un'altra epoca, per chi non ha raggiunto una gnosi totale o anche parziale. Per la dottrina recente di una reincarnazione in cui la possibilità di un ritorno a un piano dell'essere precedente o inferiore sembra rappresentare le tendenze edificanti delle estensioni religiose, dove forse sono incorporati elementi popolari non vedici, cfr. A.K.C Yakşas I, p. 14, nota 1. L'idea di una rinascita effettiva su qualsiasi piano precedente nel caso di una "reincarnazione speciale" (avatāra) è espressamente evitata, vale a dire, nel caso del Buddha, dalla dottrina del nirmāna-kāya, una dottrina che corrisponde all'eresia docetista nel cristianesimo (il Figlio dell'uomo = nirmānakāya, Cristo in gloria = sambhogakāya, Cristo come Logos = dharma-kāya).
La parola karma non dovrebbe essere tradotta con "causalità", ma semplicemente con "opere", "azione" e così via. Nella misura in cui possiamo pensare a causa ed effetto come separati nel tempo, la parola apūrva, "latenza", "non immediatamente", rappresenta l'equivalente più vicino di "causalità"; la dottrina pūrva-kara-kŗta-vāda, "la dottrina del dovuto a un'azione precedente" afferma che l'azione antecedente determina l'evento presente. Cfr Edgerton, Mīmāmsā Nyāya Prakāśa, New Haven, 1920. La "reincarnazione", come intesa dai buddisti (e ora dai teosofi), non è una dottrina vedica. Anche la discesa dei Pitŗs, "Genitori" (un termine collettivo) non è un ritorno degli individui in quanto tali a uno stato precedente dell'essere, ma, in un modo molto più generale, l'operazione imprevedibile (adŗşţa) di cause antecedenti o "Ereditate" nell'effetto presente. Dēvayāna e Pitṛyāna sono l'ascesa e la discesa della scala di Giacobbe
4 Mahā-Pralaya, in termini cristiani il "Giudizio Universale". Quelli "giudicati" e ammessi al "paradiso", cioè l'immortalità assoluta e non contingente, corrispondono a coloro in termini vedici che hanno raggiunto una realizzazione parziale seguendo
il pitŗ-yāna o deva-yāna: i giudicati e i "dannati" a quelli la cui schiavitù (pāśa, individuazione, ignoranza, peccato) è stata tale da precludere la possibilità di una concessione anche parziale e differita (krama-mukti) e deve quindi attendere in una latenza "eterna" ma non eterna, la loro rinascita mortale in un altro Tempo (kalpa), quando naturalmente si presenterà di nuovo la possibilità di ottenere o meno una realizzazione totale differita o immediata. La "dannazione" in questo senso, vale a dire un'autocondanna a una latenza infinita (sebbene non eterna), un annichilimento relativo (sebbene non assoluto), viene giudicato a coloro che concepiscono l'Ego come il Sé, pensando che ad agire "Per amore del Sé" non significa altro che soddisfare ogni desiderio dell'Ego, servendo il corpo qui e ora; coloro che vivono secondo un "Asura Upanişad" come questo "periranno", Chāndogya Upanişad, VIII, 8. In termini cristiani, la "Caduta" consisteva in un'affermazione di indipendenza, auto-sussistenza, dell'Ego (l'affermazione di Satana all’ “uguaglianza” con Dio). Lo stesso in natura, è descritto come mangiare il frutto dell'Albero della Conoscenza del Bene e del Male (che è l'Albero della Vita concepito in termini di “coppie di opposti”). Questo Albero può essere visto dal Sé con grande gioia, mentre cresce nel Giardino della Vita (pranarama); ma il suo frutto (“le cose come sono in se stesse”, non come “sono in Dio”) assimilato (tadākŗtvā) dall'Ego, è veleno mortale (visā, cfr. √vis in altri sensi); mangiare del frutto è assumere ciò che è nulla in sé, quindi "Peccato Mortale" contro lo Spirito, Morte dal punto di vista della Vita Eterna. Solo il Sé può ingoiare un tale veleno e tuttavia Vivere: come fa Śiva quando da un'altra immagine il dvandva viene prodotto alla Zangolatura del Mare di Latte ("Acque", le possibilità dell'essere), i cui segni sono la macchia blu-nera sulla sua gola come Nīlakanţha, Vişakanţha, Vişāgnipā, e la sua "dipendenza" dalla droga. L'apparente sottomissione del Sé alla tragedia (arta) della "vita", che ha accettato il dolore, è la passione di Dio e di ogni uomo.
[Nella nota 21 l'autore cita ampiamente, parola per parola, il suo articolo "Mahā-Pralaya and Last Judgment"].
5 I bodhisattva sono considerati ājānaja-devāh "angeli naturali" (Taittiríya Upanişad II.8) o come "angeli generati"; o come nati, e poi come karma-devāh (idem), cioè come "angeli riguardo alle opere", la cui durata è mantenuta dopo la morte come Salvatori o Intercessori fino alla fine del Tempo, o forse sempre nel Tempo del Tempo, indipendentemente dal fatto che la totale mancanza di respiro (nirvāna) sia sempre a portata di mano. Bodhisattva di questo tipo corrispondono agli Apāntaratama Vedici e ad altri, la possibilità della cui reincarnazione (avatarana), nonostante il raggiungimento della Gnosi Perfetta, è esaminata da Śankaracārya, Commento al Vedanta Sūtras III.3.30, 31. Il seguente passaggio si applica particolarmente al caso di un Bodhisattva: "Nel caso di esseri di questo tipo, che a causa di particolari lavori sono stati designati per particolari uffici, l'effetto delle opere sorte per la carica non scompaiono prima che tali cariche siano state completamente adempiute. Una tale discesa implica una Passione, di cui l'Abhinişkramana di Siddhārta fornisce un esempio specifico.
6 Sia "Dio" che "dio" dovrebbero essere esclusi dalle traduzioni dei testi pali, dove Brahmā non è la divinità suprema, ma solo il più alto degli angeli, e dove Buddha non è ancora "divinizzato".
Edited by amarisia - 24/11/2020, 00:22 -
.
SAGGIO SULLA TRADUZIONE
A. K. Coomaraswamy
CAPITOLO I - LA TRADUZIONE:* MĀYĀ, DEVA, TAPAS
Le traduzioni esistenti dei testi vedici andrebbero considerate in relazione al loro valore originale, cioè come sādhanā, mezzi per la realizzazione ma da un punto di vista letterario possono essere considerate solo come "traduzioni letterali", di uso reale solo come strumenti nelle mani di studenti che possano e vogliano prendersi la briga di consultare i testi originali. Questo vale a dire che i libri sacri dell'est sono inaccessibili ancora oggi per quelli - che sono la vasta maggioranza - che non possono leggere né ricorrere ai testi originali. L'unico avvicinamento possibile tra l'est e l'ovest dovrebbe effettuarsi intellettualmente e qui si trova il primo ostacolo per una mutua comprensione.
Traduzioni erronee che non devono essere attribuite ad una mancanza di studio, né ad un dominio inadeguato delle lingue orientali da parte degli eruditi, bensì piuttosto ad un uso inadeguato del loro stesso linguaggio. Non è affatto esagerato affermare che traduzioni fuorvianti sono anche dovute ad una parzialità religiosa inconscia nelle menti, o piuttosto nei cuori, degli eruditi. I quali, oltre a non avere nessuna facilità di riferimento per quel che riguarda i principi primi, spesso sono pure inconsciamente restii ad ammettere che una dottrina non cristiana abbia un significato equivalente a quel che ha significato per loro una dottrina cristiana accettata, o se non per loro individualmente, almeno per la tradizione europea. D'altra parte, supponendo un'assenza totale di qualunque parzialità religiosa negli eruditi moderni, la loro prospettiva puramente scientifica e la loro educazione speciale renderanno, inevitabilmente, quasi impossibile l'accesso ad una conoscenza della metafisica, della teologia e della letteratura mistiche cristiane nell’unico luogo dove si trova la terminologia che si richiede per una traduzione adeguata. Termini come non-incarnato, inconsapevolezza, abisso, processione, spirito, espirazione, essenza, natura, compendio, ipostasi, sguardo, magia, angelo, consonanza o conoscitore sono loro interamente sconosciuti come significato tecnico. I traduttori orientali, che hanno acquisito vocabolario e punto di vista principalmente dalle opere edite da eruditi europei, sono limitati in maniera simile.
In illustrazione di quello che si è detto offro suggestions raisonnées sulla traduzione di tre parole sanscrite ben conosciute, Māyā, Deva, e Tapas proponendo che devono essere tradotte congruentemente per "Magia", "Angelo" e "Intento", o che devono essere lasciate nelle loro forme originali senza che siano tradotte.
MĀYĀ
Māyā è uno dei nomi di Prakṛtī, il potere formativo o agente di manifestazione in Īśvara, cioè nel Sé auto-determinato (Ātman), il Sé in cui Puruşa e Prakṛtī sussistono come principi coniugati. In altre parole, nell’estensione del Sé:
Purușa è "ciò di cui"
Ākāśa "ciò in cui"
Maya "ciò per cui" può esserci manifestazione, attualità (satya), "vita".
Questa manifestazione, erroneamente chiamata "natura", che è il mondo fenomenico (jagat, loka), esiste solo in atto e non smette mai di essere.
La dottrina Māyā-vāda non afferma che il mondo è Māyā [illusione]e nemmeno che il mondo non diventa ma semplicemente che il mondo diventa in un certo modo, vale a dire, che ha Māyā come base (pradhāna) o come mezzo per diventare. La dottrina Śūnya-vāda non può essere separata da quella di Tathātā, “realtà sensibile”, né da quella di Yathābhūta (conforme agli elementi), “Così com'è”, non afferma che il mondo non diventa; ciò che afferma è che il mondo è simultaneamente "Vuoto" e "Reale". Cioè, il mondo è irreale nella misura in cui lo consideriamo come una dualità di principi auto-sussistenti (svavasthitā) separati ma reali nella loro realtà, “così come sono”.
Questo è solo un altro modo di esprimere il punto di vista del vedanta. Oltre a questa, l'unica dottrina concepibile potrebbe essere chiamata dottrina Ātmā-vāda, con riferimento alla dottrina dell'Atman come male interpretata nel Buddismo primitivo, dove si suppone che i Veda postulino l’Ātman (Sé) come Soggetto in relazione a un oggetto; è sufficiente sottolineare che, in effetti, l'Atman "non è così" (neti, neti).
Quindi ciò che il Vedanta nega è che il conoscitore e il conosciuto, ecc. (sebbene concepibili separatamente dal nostro punto di vista), “siano” entità separate e auto-sussistenti (svavasthita, svayambhü); ciò che afferma è che il conoscitore e il conosciuto, ecc. “sono” aspetti congiunti del Sé (Ātman), il Sé che si manifesta nell'Unità dell'Atto Puro come il Divenire del Mondo.
In altre parole, il mondo è sia il Sé (Ātman) che la realtà sensibile (Tathatā); tuttavia, la nostra comprensione empirica del mondo è erronea (Avidyā).
«Con la mia Māyā, io (il Sé) divento (il mondo)».
Allo stesso modo in cui né l'agente né l'agire sono sinonimi di atto, così Māyā non è nemmeno il mondo (jagat, loka) delle esistenze. Māyā può essere chiamato Moha, delusione o illusione, cioè ciò con cui il mondo viene ingannato (mohita) ma quegli esseri illusi (mudha) di natura decaduta (asura-bhāva) la cui pura Intelligenza (prajňā) è stata portata via da Māyā, non sono essi stessi illusioni e, per quanto remota possa essere la loro Liberazione (māyā-nivŗtti, Svetāśvatara Upanişad I.10), anche di questi si può ancora dire "Quello sei tu". Da quale rete (jāla, kalila) il Mondo viene allora ingannato,
«così da non conoscere Me (il Sé)?»
Dalle proprietà (i tre guna, vale a dire, energia, mobilità e inerzia) che sono percepite in modo diverso negli esseri, così che si distinguono reciprocamente e dalle "coppie" (dvandvāu), cioè le nozioni con cui il mondo è visto come tesi e antitesi.
L'illusione dell'ego consiste nella sua percezione errata del mondo: come una pluralità di unità auto-sussistenti, una percezione che include l'ego stesso e nel suo conseguente attaccamento o avversione ad altre unità in quanto tali. Questa "delusione", nel suo aspetto personale, abhimāna, egoità, "io" è il "peccato originale" ed è condiviso da Dio stesso, nella misura in cui Dio è nel mondo come Puruşa, la Persona, l'Uomo Eterno.Ma attenzione, è un aspetto dello stesso inganno concepire Dio (in Sé stesso) oggettivamente, cioè come se avesse in Sé una potenzialità non completamente attualizzata nella totalità del divenire simultaneo, inganno che consiste nel concepire "Lui" come altro dal mondo sub specie aeternitatis.
Ora, negare al mondo l'auto-sussistenza non è una negazione di nulla, se non nel senso in cui neghiamo la realtà delle corna di una lepre, o come se negassimo che l'onnipotenza possa fare ciò che è stato o potrebbe essere nel tempo (e che, di conseguenza, è al di là del tempo), indipendentemente dal fatto che maturi o meno nel tempo o dall'altra riva del tempo. Non c'è bisogno di osservare che ciò che viene chiamato azione, vita, cambiamento ed eufemisticamente "progresso", in realtà non rappresenta nient'altro che una sequenza di reazioni dell'ego a qualità e coppie di opposti e, che, dal punto di vista vedico, l'insieme di tutte queste reazioni funzionali e inconsce non rappresenta la Vita ma solo il "vivere".
Ad esempio, l'acquisizione di informazioni non è "Vita" ma solo una reazione del conoscitore verso un fatto che è noto; mentre, la conoscenza come Realizzazione (o Verifica) è Vita, vale a dire, la Vita del Sé, che non è né conoscitore né conosciuto, ma di per sé, come adaequatio* rei et intellectus, come atto immediato ed eterno. Allo stesso modo, l'arte è Vita, una Vita che non è di chi vede, né di chi è visto, che non è dell'artista né dell'opera ma è in se stessa, come consonantia diversorum (sanscrito sādiśya), una devozione e un desiderio (bhakti, prema, kāma) che non sono né nell'amante né nell'amato ma nell'incontro dell'amante e dell'amato nella caverna senza dimensione del cuore.
«Certamente, non per amore di un angelo, né di marito, né di moglie, né di essere, né di alcun bene amato, ma per amore del Sé»», Brihadāranyaka Upanişad II.4.5, e
«Colui che si avvicina ad un angelo (diverso dal Sé ), pensando “Lui è uno e io sono un altro”, non sa (nasa veda)», idem L.4.10.
Quindi, dal punto di vista vedico, la "Vita" è solo come viene così immediatamente sperimentata nel cuore della "nostra" coscienza, nel Sé Trascendentale ed esteriormente si manifesta con assoluta facilità o spontaneità (sanscrito sahaja, cinese shén, islamico islām, rassegnazione cristiana) senza ansia o motivo (a-sakta), come azione che non è azione.
Il "Vangelo" dei Veda, sebbene il Veda parli in termini di conoscenza e non secondo bhakti-vāda (religione), è la dottrina che questa liberazione ed espansione, nel senso più pieno delle parole, è sempre virtualmente realizzata ed è sempre effettivamente realizzabile:
"Il Regno dei Cieli è dentro di te",
"Oggi sarai con me in Paradiso" .
Māyā quindi è tecnicamente "natura" in senso stretto e, non "Natura" come mondo, che dovrebbe essere propriamente descritto come "natura", prakrtija o prākŗta; Māyā è il mezzo attraverso il quale viene effettuata la manifestazione.
Il Creatore (Prajāpati, ecc., o Īśvara qua Prajāpati-Vāc, Padre e Parola), come maestro di questo mezzo, è indicato come Māyāvin; il mondo è māyā-maya "fatto di" o "nel modo di" māyā, "magico". Inoltre, le sue creazioni, produzioni o manifestazioni sono confrontabili con quelle del mago mortale, la cui indra-jāla ("la cui rete di Indra") è un inganno (moha-kalila) o un incantesimo (vaşī-karana) analogo a quello del mondo come lo percepiamo coi nostri sensi. In questo senso, "magia" e "mago" sono esemplificati nel "gioco" (Līlā) e nella persona di Merlino, come descritto nella versione inglese del XV secolo di un romanzo di Merlino, che non esiste più per intero :
«Secondo Merlino ... “potrei costruire un Castello qui, e potrei farlo con una moltitudine di persone fuori che vorrebbero assalirlo e anche con una moltitudine di persone dentro che vorrebbero difenderlo. Eppure vorrei farlo con maggiore maestria, perché potrei andare su quest'acqua e non bagnarmi i piedi e potrei anche fare un fiume dove non c'è mai stata acqua.”...
...Tutto questo veniva fatto facendo arrivare tutte queste cose dalla foresta (Brioke) ed essere messe in cerchio "in mezzo alla terra" e dopo che erano "erano esistiti per molto tempo", alla fine della giornata, li riportava nella foresta, dove sparivano "all'improvviso, così che tutto tornava al luogo da cui era venuto.»
Come dice Bōhme, «Il Mago ha il potere in questo Mistero (Mysterium Magnum, l'emanazione divina) di agire secondo la sua volontà e fare ciò che vuole», nella misura in cui «ogni mistero è lo specchio e il modello di un altro» anche se «deve essere armato in quell'elemento in cui vuole creare.»
Ancora una volta, è lo stesso Bōhme a spiegare il mondo come la creazione del Mago Divino facendo uso della Magia Divina:
«La Magia è la madre eterna, la madre dell'essere (esistenza) di tutti gli esseri. lo stato originario della natura. una matrice senza sostanza, ma che si manifesta nell'essere sostanziale. Ha in sé il Fiat ... nella Magia sono tutte le forme dell'Essere di tutti gli esseri. È una madre nei tre mondi e fa ogni cosa secondo il modello della volontà di quella cosa. Non è comprensiva, ma creatrice secondo la comprensione e tende al bene o al male. La magia è la madre da cui proviene la natura e la comprensione è la madre che proviene dalla natura. Insomma, la Magia è l'attività nella Volontà dello Spirito.»
Quindi, la Magia è l'abilità o l'arte di Dio attraverso la quale manifesta o produce il divenire del mondo; e in altri esseri è per partecipazione, o come "specchio o modello dell'altro". Nient'altro è richiesto per provare che il sanscrito "Māyā" dovrebbe essere tradotto con la parola "Magia". -
.
Per esempio, il Figlio crea il Padre tanto quanto il Padre il Figlio, perché non può esserci paternità senza filiazione, e viceversa, e questo è ciò che si intende per “relazione opposta”. Allo stesso modo, non può esserci una Persona (Puruşa) senza Natura (Prakŗtī), e viceversa. Ecco perché nella “mitologia” metafisica incontriamo “inversioni”, come per esempio, quando nel Ŗg Veda, X.72.4, Dakșa nasce da Aditi come suo figlio e anche lei nasce come sua figlia; o X.90.5, dove Virāj nasce da Puruşa, e viceversa. La metafisica è coerente, ma non sistematica: il sistema si trova solo nelle estensioni religiose, dove un dato ordinamento delle Persone diventa un dogma ed è precisamente da tali “questioni di fede”, e non da una differenza di basi metafisiche, che una religione si distingue da un'altra.
la via nascosta
Posts written by amarisia |